come ballo che è. Orbene, cari amici e lettori de"Il peccato veniale" riprendiamo il nostro viaggio tra presente , passato e futuro, trattando oggi, il ballo cosi com'è concepito ai nostri giorni e come ci si è arrivati.
La storia del ballo moderno può essere catalogata in tre fasi: La prima è identificata come di rottura con il balletto classico e di ricerca, e risale circa alla fine del XIX secolo e inizi del XX. La seconda fase definita, delle tecniche, e sorge tra gli anni trenta e gli anni quaranta. Infine la fase di innovazione, che va dal secondo dopoguerra ad oggi.
E' doveroso fare un'ulteriore distinzione fra ballo moderno statunitense e il ballo moderno centroeuropeo. Favoriti dai numerosi scambi culturali fra gli artisti, i rapporti fra i due continenti sono sempre rimasti costanti.
Infatti all'inizio del XX secolo, la voglia di cambiamento, fece si che si sviluppassero due correnti: quella dei Ballets Russes, che proponeva un rinnovamento dall'interno, e quella che sosteneva la creazione di un nuovo tipo di ballo. I primi ballerini moderni erano alla costante ricerca di...
un ballo che fosse più espressivo di quanto non lo fosse il balletto classico, per questo motivo alcuni coreografi di balletto tra i quali Michel Fokine, si ispirarono ai balli di tradizioni orientali. Isadora Duncan, per esempio, tolse via per prima le scarpette con le punte e il tutù.
Andò in scena a Parigi, nel 1900, a piedi nudi, con i capelli sciolti e indossando un'ampia tunica, poiché il suo scopo era quello di ritrovare i gesti naturali ed esprimere le passioni, imitando i movimenti dei ballerini greci dell'antichità. La Duncan inoltre sosteneva che l'origine di tutti i movimenti del corpo, risiedeva nel plesso solare, per questo motivo propose un ballo in cui fosse possibile muoversi alternando contrapposizioni alla forza di gravità, ad un leggero abbandonarsi ad essa stessa.
Martha Graham cercò di far rivivere nei suoi spettacoli i grandi miti tratti dalla Bibbia, dalla mitologia greca o dall'Oriente. Solitamente i personaggi rappresentati erano per lo più femminili, ritratte in momenti di grave crisi psicologica ed emotiva. I temi cardini delle sue creazioni erano di genere etico, legati ai drammi della società americana.
Volendo accontentare la nostra amica Clavirste, la quale ha espresso il desiderio che si potesse trattare la storia ed il significato di uno dei tanti balli che ad oggi si pratica, spernado di non deluderla troppo vorrei trattare un ballo di origini tedesche: Il valzer.
Si diffuse inizialmente in Austria e nel meridione della Germania, il valzer invase molto presto gran parte dell'Europa: dalla Francia (dove fu introdotto da Maria Antonietta) alla Russia, dall'Italia all'Inghilterra, affermandosi con nobile fascino un ballo internazionale. Il successo che ebbe fù dovuto al fatto che oltre ad avere un carattere fluente e orecchiabile della musica, impegnava per la prima volta la coppia di ballerini a ballare abbracciata.
Il valzer si affermò a Vienna all'inizio del secolo XIX con Johann Strauss padre e il suo amico, collega e rivale Joseph Lanner.
Successivamente, il valzer viennese, conservò un andamento veloce e spigliato, altresi in Francia il nuovo ballo toccò il massimo della popolarità all'interno del genere operettistico, acquistando un carattere più languente e sentimentale.
In Inghilterra alla fine del XIX secolo si affermò il valzer lento.
Molti compositori dell'Ottocento si dedicarono alla composizione di valzer furono Josef Strauss, Eduard Strauss, Emile Waldteufel, Charles Gounod, Jacques Offenbach, Carl Michael Ziehrer.
Nel secolo XX il valzer viennese sopravvisse nelle operette di compositori come Franz Lehar e Robert Stolz, ma anche i compositori espressionisti e pre-espressionisti di area tedesca come Gustav Mahler a Richard Strauss e Alban Berg, lo usarono abbondantemente, sia pure con uno spirito nuovo, direi quasi dissacratorio.
Il valzer fu usato finanche nella musica jazz. Uno dei principali esponenti fu Bill Evans che molto spesso utilizzava il tempo 3/4 o anche il 5/4 nelle sue improvvisazioni. Non è possibile non citare il tipico valzer romagnolo (famosi sono quelli di Secondo Casadei) che si balla ancora oggi nelle balere.
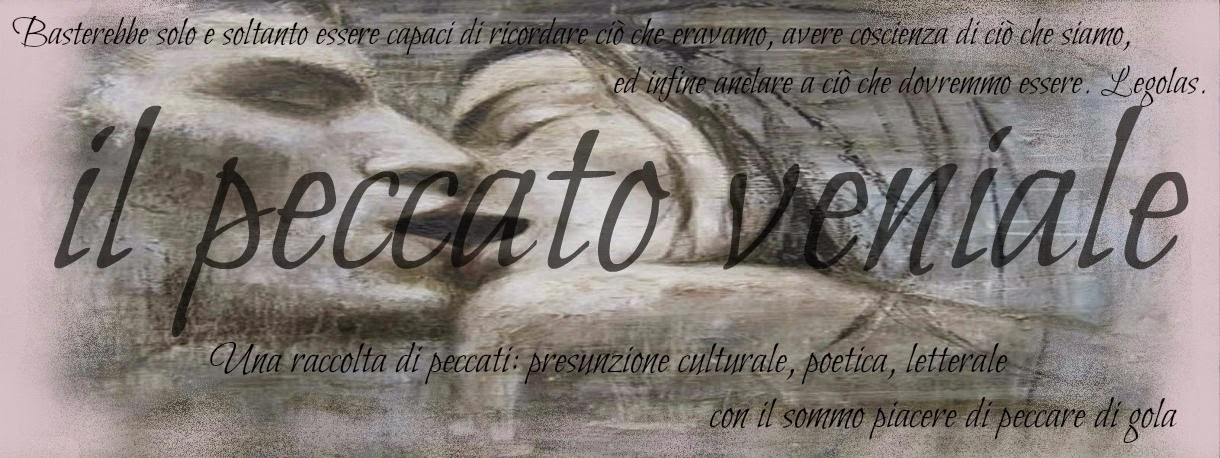



3 commenti:
il nostro equilibrio interiore, la nostra statura spirituale, quella che ci rende belli, affascinanti, quella che ci dona un'alone di splendida fulgida luminosità. Vivi la tua vita, pienamente come sai fare tu, e come vuoi tu,
quanto è bello il commento lasciato a dondelion... grazir leggerti è un piacere
Ti sono grato, per l'apprezzamento, vorrei solo che la docissima dandenlion possa recepire e ricevere facendole sue, le passioni e gli affetti che si stanno convolgendo verso lei. Provo affetto per la cara dandelion, mi ha donato conforto, serenità, gioia e pace con il suo vivere la vita cosi come lei solo sa fare, e mi sento turbato alquanto sapendola in difficoltà. Possa il sole e la luna , le stelle tutte renderle ciò che gli spetta.
Lunga vita e prosperità strega...streghina! ;)
...Non mi hai affatto delusa, anzi...il valzer e' per me una danza affascinante..secondo me molto elegante...grazie per avermi accontentato, la tua scelta e'stata decisamente azzeccata in pieno,anche se non ho mai azzardato un passo di valzer ;) di questa danza sapevo solo che si balla volentieri nelle moderne sale da ballo da persone di qualsiasi eta'grazie mille!!! Ti seguo con piacere!
Posta un commento